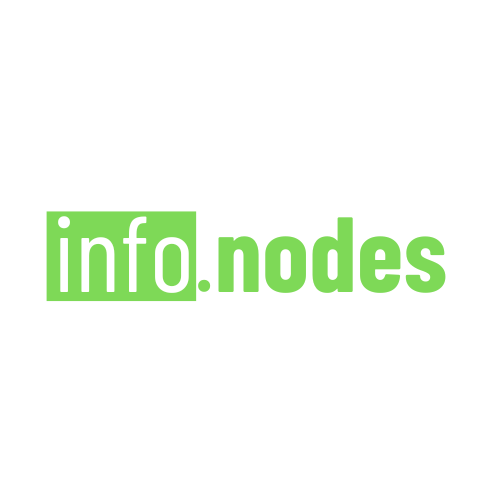Gli impedimenti: il peso del passato (1) e l’omogeneità dell’individualismo (2)
Viviamo una profonda e lacerante contraddizione: siamo riluttanti all’idea di unirci sotto la vasta ombra di una grande battaglia, e di scendere in piazza nel suo nome, o di chiedere il conto di quanto subiamo a chi perpetra l’oppressione, eppure, rimaniamo sempre in ricerca, assetati, di un vago senso d’appartenenza, che in noi muta forma come muta forma nel corso della storia, ma non ci abbandona.
Questo contrasto contemporaneo poggia sulla ferma convinzione che le convenzioni culturali – siano esse categorie o simboli –, siano facilmente smascherabili e stantie, incapaci, o soltanto inadatte, a raccontarci il presente.
Non a torto spesso: tra gli altri, il concetto di classe ha perso incisività, forse persino senso oggi, e ha smesso di comunicarci qualcosa di urgente, ma dalle sue ceneri che ne è nato?
Sarebbe superficiale la risposta: non è necessario che qualcosa prenda le veci di queste vecchie e impolverate categorie che muoiono.
Perché in fondo, affinché uno sforzo collettivo si faccia coscienza dev’essere orientato da qualcosa che, apparentemente simbolico, trasfiguri il pensiero in parole, e ciò che appartiene alla singola biografia in comune.
E se è questo sforzo che dobbiamo cercare di recuperare, sarà necessario indagare le cause di questa interruzione di corrente narrativa: come raccontare le sfide che ci coinvolgono?
Forse si è persa una certa quota di fiducia nel simbolico. Dall’anacronismo resistente dei simboli a noi pervenuti e dal pullulare rumoroso di semplici e potenti nuovi simulacri, emerge una cinica disillusione.
Questa progressiva disillusione di ciò che si erge a simbolo, evidentemente, ora percepito come nulla più che un’astrazione condivisa - si sente, a ragione, il grido di un passato mai troppo lontano – mina la disposizione a una comunanza d’intenti. I simboli celano, e celando mostrano.
La rappresentatività di poche coordinate geografiche, culturali, sociali, sfaldandosi, non ci parla più.
La convinzione di possedere dieci infallibili diottrie nel riconoscere i paradossi e le infermità dei movimenti di protesta, inibisce alla base ciò che ancora può esistere di progressista, da pensare o incarnare.
Tentativi goffi, po’ irruenti e caotici di raccontare una personale visione del mondo, si diluiscono in un discorso pubblico furioso, e ribaltano gli estremi dell’equazione che trasforma l’individuale in movimento: ben definite e marmoree coscienze voglio indurre uno sforzo collettivo; ma attecchire è complesso, e per chi più di altri sente propria questa orfanità e pretende un certo grado di semplificazione e chiarezza immediata, la tensione muta in dogma e nascono forme radicali, deformate, di quella insofferenza comune in origine.
Questo desiderio, che sacrifica sull’altare dell’immediatezza una certa complessità, è anche espressione di un'abitudine al disimpegno.
David Foster Wallace ha scritto tanto del potere sedativo dell’Ironia e dei fumi narcotici che ammantano i prodotti ultra-sofisticati di intrattenimento, della traiettoria inconfessabile che l’attitudine solitaria e autoindulgente, che soggiace alle innumerevoli forme di dipendenza che ci affliggono, rende esponenziale, creando movimenti fragili e fin troppo omegenei.
(Si consiglia il saggio di Wallace ‘E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction’)
Una nuova strada: dal lavoro (3) all’ambiente (4)
Parafrasando Mark Fisher ci battiamo per ciò che siamo in grado di immaginare.
Essere in grado di immaginare ciò che di più urgente e pressante ha a che fare con noi, e la nostra sfera più individuale, sapendolo mostrare, ci permette di definire i confini di ciò che siamo disposti davvero a tollerare e di ciò che moriremmo per cambiare.
(Il blog in cui Fischer ha espresso il suo pensiero)
Ma perché l’immaginazione sia un vettore dev’essere estremamente concreta, e vera, e nascere dalla piena e consapevole sofferenza di ciò che viviamo.
Da dove partire per riconquistare quella dignità nel farci araldi di un sentire comune? Trovare la pazienza di rappresentare con una metodologia plurale, il grumo di desideri e sogni che si iscrivono nel nostro tempo?
Forse capovolgendo il percorso già battuto che pare oggi un vicolo cieco.
Il più profondo meccanismo di autosufficienza e affermazione sociale, il lavoro, potrebbe non saper fare da innesco.
Da sempre un fattore di continuità e profonda cesura generazionale, oggi ha perso centralità: l’affermazione del proprio stare nel mondo pare meno vincolata a una parallela affermazione lavorativa. In un certo senso, questa prospettiva lavoro-centrica è sfibrata dalla difficoltà pratica di rendere il lavoro un mezzo d’indipendenza e conquista: la vita, nei centri urbani, presuppone redditi proibitivi e privilegi, e il mercato del lavoro stagnando predilige poche e specializzate competenze.
Un certo benessere duramente conquistato, ancora certamente lontano per molti e sempre troppi dimenticati, ha modellato i desideri legati ai tempi e ai luoghi del lavoro.
La salute mentale acquisisce rilevanza, il rispetto dei propositi integrativi, e ambientali – almeno nei più giovani, o forse in chi detiene un seppur minimo potere contrattuale – è assunto a vincolo, e tutto questo contribuisce a una transizione, ancora lenta, che vede il concetto stesso di carriera, costituire più che un fine, un mezzo.
Le recenti battaglie per l’equilibrio lavoro-vita privata sono l’esempio lampante di come il lavoro abbia perso la sua centralità nelle lotte collettive ma sia diventato strumento, soprattutto per i più giovani, per ottenere dei miglioramenti per il proprio benessere personale.
Una generazione sente nella carne la propria battaglia, difficilmente la sceglie scorrendo un catalogo di possibili cause alle quali immolarsi e il lavoro si è defilato qualcosa ha preso il suo posto.
E se le questioni sul lavoro non sanno far ardere i cuori di una generazione, la questione climatica, inizialmente senza esser presa sul serio, diviene sempre più la battaglia di quest’epoca.
Non soltanto per la portata della sua sfida, né per ciò che c’è in gioco o per gli sforzi che sono richiesti a strapparla agli spazi sfumati delle astrazioni, ma anche per tutto ciò che racchiude, in termini di questioni sociali e politiche e di sguardi al futuro.
Esacerba i conflitti interni a una comunità scientifica che fatica ad affermare sé stessa, e il rapporto dello status-quo con le manifestazioni frequenti e clamorose del dissenso, con la razionalità che si diluisce nell’emotività, e i limiti di un sistema economico che disincentiva ogni proposito diversamente-interessato o improduttivo.
Dobbiamo saper rendere il cambiamento climatico una eco, e un potente catalizzatore, perché ci si mobiliti per ciò che difficilmente saprebbe accendere e far riempire le piazze, siano esse virtuali o fisiche.
Null’altro oggi sa parlarci di privilegio e sfruttamento, sforzi collettivi e resurrezioni, quanto questa questione che, come nessun’altra, ha saputo mobilitare i più giovani in diversi movimenti con anche forti connotazioni politiche.
Per tornare a parlare anche di lavoro, siamo portati e in parte persino costretti a parlare di clima.
Ancora troppo spezzettate, isolate, poche proteste sorgono e a noi appaiono mute o travisate, pochi gesti a favor di camere, discese in piazza scoordinate definiscono questa battaglia, che di una linearità e di una contingenza ha continuo bisogno.
Il coraggio di accettare quest’investitura che esprime il nostro tempo, e che costituisce un pretesto simbolico finalmente potente e profondo e un vivido coinvolgente immaginario, sarà l’innesto che riaccenderà la fiducia nell’atto politico, quell’agire quotidiano che ci appartiene e troppo facilmente, se mai illuminato, si assopisce.